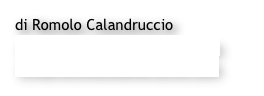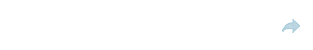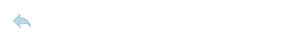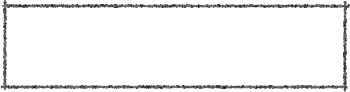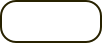

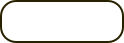
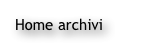
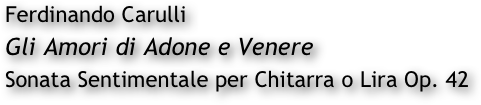
NARRATIO = Trama della storia (parte centrale in cui vengono esposti gli argomenti).
(punti 2 e 3) Utilizza una Narratio longa: in tal caso Quintiliano raccomanda l’inserimento di un epigramma nei casi in cui occorra dare unità a elementi disparati. Questo epigramma può essere identificato con il secondo tema dell’introduzione che, come si vedrà in seguito, verrà utilizzato in tutte le sezioni comprese nei punti 2 e 3.
CONCLUSIO = Finale (parte conclusiva in cui vengono riassunte le argomentazioni e tratte le conclusioni).
(punto 4) Potrebbe benissimo contenere le caratteristiche della Peroratio in adfectibus, perché in questo caso è d’obbligo che si concluda l’orazione con i passaggi e le espressioni con cui si è iniziato.

Tutte le sezioni andrebbero a formare un’opera in un solo atto strutturata come segue:
Personaggi
Adone …………… Tenore
Venere ………… Soprano
Marte …………… Baritono
Proserpina ……… Soprano
Cacciatori ………… Coro
Struttura dell’Opera
Ouverture: Introduzione;
Quadro I:
Venere e Adone amoreggiano;
la gelosia di Marte.
Quadro II:
Venere e Adone vanno a caccia;
la caccia incomincia.
Quadro III:
Adone si perde;
gli appare davanti un cinghiale;
la voce del cinghiale;
Adone si batte con il cinghiale;
Adone ferisce il cinghiale;
il cinghiale gli salta al collo;
il cinghiale uccide Adone;
la morte di Adone;
Adone spira.
Quadro IV:
Venere cerca Adone;
ella resta sorpresa vedendo Adone morto;
disperazione di Venere;
il pianto di Venere.
Quadro V:
Proserpina intenerita promette di ridare la vita ad Adone;
Venere la ringrazia;
Adone ritorna in vita.
Finale
Cavatine ed Arie
Marte: l’ira di Marte (cavatina).
Venere: Venere cerca Adone, la disperazione di Venere (Cavatina);
il pianto di Venere (Aria); Venere ringrazia Proserpina.
Proserpina: Promette di ridare la vita ad Adone (Aria).
Duetto: Venere e Adone amoreggiano.
Elementi caratterizzanti del brano:
a)Utilizzo delle figure retoriche40;
b)La nota FA5 (XIII tasto) come culmine dell’estensione del brano, sfruttando così la massima l’estensione che normalmente Carulli utilizza nelle sue opere. Di fatto, nei suoi studi, nei Metodi41 e anche in una rappresentazione ed esplicazione delle note sul manico della chitarra (Op. 61 pag. 3), non si spinge mai oltre il XII tasto;
c)Uso frequente dell’intervallo di 6a sia come intervallo armonico o melodico che come ambito di sviluppo delle frasi;
d)Caratterizzazione delle idee costruite sui due gradi forti di ogni tonalità (I e V), tranne gli episodi dove non sono presenti i due protagonisti, come in: la gelosia di Marte; Venere e Adone vanno a caccia. Sul I grado viene generalmente proposta una costruzione ritmica e melodica più decisa e forte, identificabile con il personaggio di ADONE; sul V grado, invece, viene proposta una costruzione ritmica e melodica puntata e indecisa42, molto più cantabile e identificabile con il personaggio di VENERE. Non bisogna inoltre dimenticare “l’attrazione” che questi due gradi esercitano l’un verso l’altro nelle leggi dell’armonia musicale.
-
e)Largo utilizzo del cromatismo con bicordi di terze:
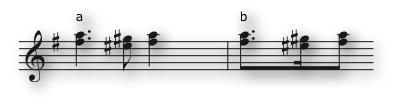
-
f)Largo uso dell’elemento ritmico puntato Pirrichio (nelle diverse varianti):

g)Introduzione “orchestrale” in ogni sezione dove sono presenti “personaggi che cantano”;
h)Ogni brano si conclude sulla dominante della tonalità del brano che segue (tranne l’Introduzione, Venere e Adone vanno a caccia e il pianto di Venere che terminano sulla sottodominante);
i)Ampio utilizzo della spazialità accordale, ottenuta mediante la tecnica diffusiva per eccellenza: l’arpeggio;
j)Utilizzo magistrale delle tonalità43 che andrà a creare quei chiaroscuri necessari per meglio rappresentare i personaggi ed i loro stati d’animo44, inoltre, le tonalità utilizzate consentono un ampio spazio di movimento sulla tastiera senza far mancare e l’accompagnamento dei bassi dati dalle corde gravi rispettivamente 4a - 5a e 5a - 6a ( I e V grado);
-
k) Prendendo in considerazione le tonalità d’impianto, escluse le modulazioni e le tonicizzazioni, si ottiene il seguente grafico sull’utilizzo delle tonalità, per battute, in tutto il brano:
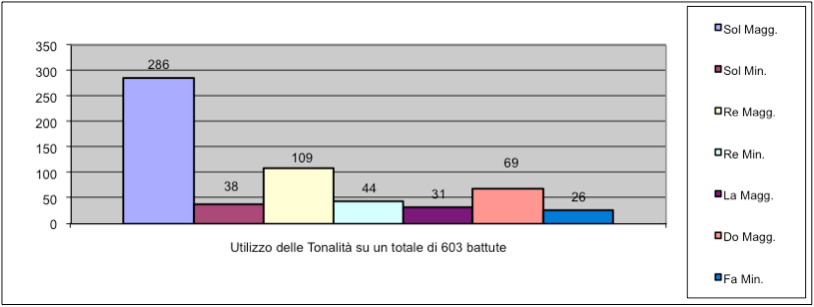
Dal grafico possiamo dedurre una visione unitaria del brano in cui la tonalità di SOL, essendo predominante, assume il ruolo di I grado, di conseguenza il RE V grado e il DO IV grado.
Le altre tonalità: Sol min., Re min., Fa min. e La Magg., vengono considerate come variante coloristica e nel caso di La Magg. come dominante secondaria del V (Re).
__________
40. Si fornirà il lettore di un’appendice con tutte le figure retoriche musicali presenti nel brano.
41. Op. 27 , Op. 293, Op. 61 e le appendici all’Op. 27.
42. Grazie un maggiore uso di appoggiature.
43 F. Carulli, Op. cit. p. 11.
“ Ogni strumento ha le sue tonalità favorite: si può suonare sulla chitarra in tutte le tonalità, ma quelle che a lei risultano migliori sono: LA Maggiore e Minore, RE Maggiore e Minore, Mi Maggiore e Minore, DO, SOL, FA. Le altre sono difficili; […]”.
44. In modo particolare lo scambio tra modo maggiore e minore di uno stesso tono.